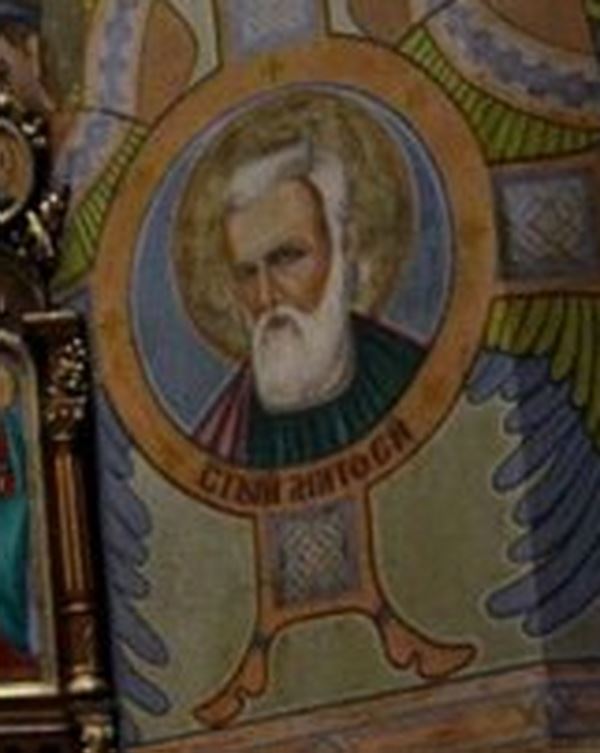Circoncisione di Gesù
1 gennaio
1 gennaio
La miniatura dal Menologio dell'imperatore bizantino Basilio II del X secolo,
che rappresenta la Circoncisione
"Il Signore è circonciso l'ottavo giorno,
come un bambino, ricevendo il nome di Gesù,
perché Egli è il Salvatore e il Signore del mondo"
(Ottavo canto del canone del Mattutino).
Secondo la tradizione ebraica, la circoncisione di Gesù venne nell'ottavo giorno dopo la nascita. Fin dai tempi di Abramo, la circoncisione veniva praticata tra gli ebrei sui bambini di otto giorni e serviva come segno dell'adesione a un patto con Dio. Nell'Antico Testamento la circoncisione (Brit Milah, in ebr.: בְּרִית מִילָה, patto del taglio Gen 17, 10-14) era un segno dell'alleanza di Dio con Abramo e la sua discendenza: "Questa è la mia alleanza che dovete osservare, alleanza tra me e voi e la tua discendenza dopo di te: sia circonciso tra voi ogni maschio" (Gen 17, 10).
Nel Libro Levitico leggiamo: "L’ottavo giorno il bambino sarà circonciso" (Lv 12:3) Questo rito era di grande importanza, poiché simboleggiava l'adesione alla religione monoteista e la sottomissione agli obblighi che ne derivavano. Il mancato rispetto di questa legge significava trasgredirla ed essere esclusi dall'appartenenza al popolo.
Il termine "circoncisione" è spesso stato usato nell'Antico Testamento in senso simbolico, quando si parla della circoncisione del cuore, delle labbra, delle orecchie, cioè della necessità di obbedire a Dio o di ribellarsi a Lui. Attraverso i profeti Dio esortava ad avere un cuore circonciso e una relazione sincera con il Signore. Così il profeta Geremia dichiarò: "Ecco, il loro orecchio è incirconciso, essi sono incapaci di prestarmi attenzione" (Ge 6, 10), "tutte le nazioni sono incirconcise, e tutta la casa d’Israele è incirconcisa di cuore" (Ge 9, 26). Ed esclamò: "Circoncidetevi per il Signore, circoncidete i vostri cuori, uomini di Giuda e abitanti di Gerusalemme".
Con la sua circoncisione Gesù entrò giuridicamente a far parte del popolo ebraico. Celebrando la circoncisione, la Chiesa afferma la fede che il Salvatore era il Dio-uomo e assunse un vero corpo umano, non uno illusorio, come insegnavano alcuni eretici. Cristo, che è simile a noi in tutto tranne che nel peccato, non aveva bisogno di alcun rito. Tuttavia, Egli adempì questa prescrizione, mostrando il rigoroso adempimento della legge del Signore e dandole un nuovo significato: quello del Nuovo Testamento.
L'evento si narra nel Vangelo di Luca: "Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo"(Lc 2, 21). Invece nei Vangeli apocrifi è stato descritto più ampiamente (in particolare Vangelo apocrifo dell'infanzia).
Nell'esegesi cristiana la Circoncisione che versa per la prima volta il sangue del Bambino Gesù è la prefigurazione della Passione del Signore. Come si spiega nel Catechismo di San Pio X, "La Circoncisione del Signore è la festa istituita per celebrare la memoria del sangue sparso da Gesù Cristo nei primi giorni della sua vita". In questo rito si prefigurava il battesimo (Coll 2, 11-12: "In lui voi siete stati anche circoncisi, di una circoncisione però non fatta da mano di uomo, mediante la spogliazione del nostro corpo di carne, ma della vera circoncisione di Cristo").
La circoncisione del cuore neotestamentaria si riferisce all'istituzione dell'Alleanza Nuova. Come spiega San Paolo Apostolo nella Lettera ai Romani: "Infatti, Giudeo non è chi appare tale all'esterno, e la circoncisione non è quella visibile nella carne; ma Giudeo è colui che lo è interiormente e la circoncisione è quella del cuore, nello spirito e non nella legge; la sua gloria non viene dagli uomini ma da Dio" (Rm 2, 28-29). La chiamata dei cristiani alla circoncisione spirituale, alla vittoria sulle proprie passioni, inclinazioni cattive, è descritta da San Paolo Apostolo: "noi siamo la circoncisione, che serviamo lo Spirito spiritualmente in Dio, che gloria in Cristo Gesù senza confidare nella carne" (Fil 3, 3).
Nella festa della Circoncisione si parla innanzitutto di sacrificio ed abnegazione. Non c'è vero servizio a Dio senza l'osservanza dei comandamenti di Dio e l'adempimento dei doveri cristiani. Ogni cristiano deve praticare la circoncisione spirituale, che è la vittoria sulle proprie concupiscenze, sulle cattive inclinazioni e sulle proprie passioni. "Poiché la vera circoncisione siamo noi", dice il santo apostolo Paolo, "che serviamo Dio nello Spirito e ci vantiamo in Cristo Gesù e non abbiamo fiducia nella carne" (Fil 3,3).
L'inizio della festa risale ai primi secoli del cristianesimo. Abbiamo ricevuto gli insegnamenti dei Padri della Chiesa del IV secolo su di essa: Anfilochio di Iconio, Gregorio di Nissa, Ambrogio di Milano e altri. Del V secolo si è conservato un dialogo sul giorno della circoncisione di Massimo, vescovo di Torino. Inizialmente la festa della Circoncisione ebbe origine e si sviluppò nella Chiesa d'Occidente, per poi passare a quella d'Oriente. In Oriente, la festa della Circoncisione divenne comune tra l'VIII e il IX secolo, perché solo da quel momento i calendari bizantini fissarono la festa della Circoncisione e la festa di Basilio Magno al 1° gennaio. Sant'Andrea di Creta (VIII secolo) scrisse un sermone sulla festa della Circoncisione e su San Basilio Magno.
La Chiesa Romana originariamente chiamava questa festa l'Ottava del Signore, perché cadeva l'ottavo giorno dopo Natale, che cadeva di Capodanno. Gli antichi pagani credevano nel seguente presagio: "Come è il primo giorno del nuovo anno, così sarà tutto l'anno". Pertanto, a quanto pare, in quel giorno si tenevano varie feste, baldorie, bevute e vari tipi di carnevali. Gli uomini si travestivano da donne e le donne da uomini. Indossavano pelli di animali, ad esempio la testa di una mucca, di un cervo o di un cane. Si travestivano da dei e dee e si abbandonavano persino alla dissolutezza. San Giovanni Crisostomo, denunciando quella baldoria pagana in occasione del Capodanno, disse: "Pensano che se il primo giorno di questo mese viene trascorso nel piacere e nella gioia, allora tutto l'anno sarà così... È un grande eccesso - dopo un giorno felice aspettarsi la stessa cosa per tutto l'anno... Un anno felice sarà per te in ogni cosa quando non ti ubriacherai il primo giorno, e quando il primo e ogni giorno farai ciò che piace al Signore" (Parola per il Capodanno).
Per contrastare le pratiche pagane, la Chiesa invita i suoi fedeli non alla gioia, ma al digiuno e alla penitenza per i peccati dei pagani con l'avvento del Capodanno. Nel suo sermone per il Capodanno, Sant'Agostino, incoraggiando i suoi fedeli al digiuno, dice: "Per porre fine alla gioia carnale e lussuriosa dei pagani, digiuniamo tutti, con l'aiuto di Dio, nel giorno della Circoncisione, eccetto coloro che, a causa della cattiva salute, non possono digiunare, e preghiamo Dio pubblicamente per quelle persone miserabili che, secondo la loro usanza pagana, trascorrono questi giorni del Capodanno nel lusso e nell'intemperanza".
Questo digiuno a volte durava anche tre giorni, come si può vedere dalla XVII regola del Secondo Concilio di Tours del 567 in Francia: "Poiché ci sono celebrazioni pagane tra le feste della Natività di Cristo e dell'Epifania, è necessario osservare un digiuno per tre giorni durante esse". Solo nel VI secolo, quando, sotto l'influenza della fede cristiana, le celebrazioni pagane svanirono gradualmente nell'oblio, la festa della Circoncisione assunse un carattere gioioso. Dopo il Concilio Vaticano II, la festa della Circoncisione nella Chiesa latina ha riacquistato il suo nome originale: Octave Domini, ovvero l'ottavo giorno dopo Natale.
Nel IV secolo, la celebrazione della memoria di San Basilio Magno fu combinata con la celebrazione della Circoncisione, pertanto la Liturgia di Basilio Magno viene celebrata in questo giorno. La festa dura un giorno e segna contemporaneamente la conclusione della celebrazione della Natività di Cristo.
Con la commemorazione della Circoncisione di Nostro Signore si conclude l'Ottava di Natale la Chiesa orientale e del rito ambrosiano celebrano come solennità liturgica. Dopo gli otto giorni dalla sua nascita Cristo venne circonciso secondo la tradizione ebraica della Milah (in ebraico: בְּרִית מִילָה), il patto del taglio presente nel Vecchio Testamento (Gen 17, 10-14). Il comando di osservare il patto della circoncisione che "sarà segno dell'unione tra me e voi" (Gen 17, 11) fu dato dal Signore al popolo d'Israele attraverso Abramo e Mosè (Lev 12, 3). Questo rito significava la sua sottomissione alla Legge di Dio, è un segno dell'appartenenza al popolo dell’Alleanza, alla discendenza di Abramo, che era l'immagine del nostro battesimo. La circoncisione della carne aveva un significato dell'appartenenza a Dio, "segno dell'alleanza" dell'Antico Testamento (Gen 17) che garantiva la benedizione.
Insieme alla circoncisione, accettata dal Signore come segno del Patto di Dio con il popolo, Egli ricevette anche il Nome di Gesù (Salvatore), come sigillo del Suo ministero per la salvezza del mondo (Mt 1,21; At 3,6.16; Fil 2,9.10). Questi due eventi, accaduti all'inizio della vita terrena del Salvatore, ricordano ai cristiani che sono entrati nella Nuova Alleanza con Dio e sono "circoncisi di una circoncisione fatta senza mano d'uomo, ma della circoncisione di Cristo, che consiste nello spogliamento della carne del peccato" (Col 2,11). Il nome stesso di un cristiano testimonia l'ingresso di una persona nella Nuova Alleanza con Dio.
La festa della Circoncisione del Signore è legata all’imposizione del Nome di Gesù, che significa "Salvatore", perché, secondo la tradizione ebraica, durante la circoncisione si dava il nome. Pertanto, questa festa è anche chiamata festa dell'Imposizione del Nome di Gesù Cristo nel nostro Paese. Nel nono canto del canone del Mattutino della festa, cantiamo: "Venite e trionfiamo nel santuario del Signore, il glorioso nome di Cristo: Gesù è stato chiamato oggi con un nome degno di Dio". La festa della Circoncisione, sebbene considerata grande, non appartiene alle dodici grandi feste. Non ha né una tradizione né una festa successiva e, di fatto, conclude la festa successiva alla Natività di Cristo. Il canone per il mattutino della festa fu compilato da Santo Stefano di Sava (VII secolo).
Nel Salmo 8, 2 si esclama: "O Signore nostro Dio, quanto mirabile è il tuo nome su tutta la terra". Il re Davide invocava: "Benedici, anima mia, il Signore; quanto è in me benedica il suo santo nome" (Sal 103, 1). Nell'altro salmo si dice: "Santo e terribile il suo nome" (Sal 111 (110), 9). Lo stesso Signore Gesù Cristo disse: "In verità, in verità vi dico: qualunque cosa chiederete al Padre, ve la darà nel mio nome" (Gn 16, 23) e "nel mio nome scacceranno i demoni" (Mc 16, 17). Nella potenza e per la gloria di questo santo Nome sono stati compiuti numerosi miracoli degli apostoli. "Nel nome di Gesù Cristo di Nazareth, alzati e cammina!" (Att 3, 6), - disse San Pietro ad un uomo storpio dalla nascita che "è stato risanato in virtù del suo nome" (Att 3, 16), perché "Nessun altro nome infatti sotto cielo è concesso agli uomini per il quale siamo destinati a salvarci" (Att 4, 12). San Paolo proclamò, che il Padre a Gesù "ha donato il nome che è sopra di ogni nome" (Ef 1, 20-21), "perché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto terra" (Fil 2, 10 -11), "e chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato" (Rm 10, 13), perciò "tutto quello che dite e fate, fate tutto nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio Padre per mezzo di lui" (Col 3, 17). San Giovanni Teologo svela: "vi sono stati rimessi i peccati in virtù del suo nome" (1 Gn 2, 12) "possedete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio" (1 Gn 5, 13).
Dare a Cristo il nome Gesù indica la santità e la potenza di quel nome e il suo grande significato per ogni cristiano. Il Signore Dio stesso ha dato a Cristo questo nome. "Essa partorirà un figlio", dice l'angelo a San Giuseppe, "e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati" (Mt 1, 21).
Prima della sua ascensione al cielo, Gesù Cristo fece ai suoi discepoli questa promessa: "Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno; imporranno le mani ai malati e questi guariranno" (Mc 16, 17-18). Il santo apostolo Paolo testimonia la santità e la potenza del santo nome di Gesù: "Per questo Dio lo ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra" (Fil 2,9-10). San Giovanni Crisostomo, spiegando le parole del salmista: "Signore, quanto è mirabile il Tuo nome su tutta la terra!» (Sal 8,2), e la forza di questo santo nome, scrisse: "In questo nome la morte è distrutta, i demoni legati, il cielo fu creato, le porte del paradiso furano aperte, gli schiavi diventano liberi, i nemici sono figli, gli stranieri sono diventati eredi, le persone divennero angeli". Le parole del salmo "Il suo nome santo e terribile" (110,9) San Giovanni Crisostomo spiegò: "E in che modo il suo nome è santo e terribile? I demoni lo temono, hanno paura le malattie; con questo nome gli apostoli hanno convertito l'universo; per mezzo di esso, invece di un'arma, David sconfisse lo straniero; realizzò la ricchezza di grandi opere; per mezzo di esso compiamo i sacri misteri" (Conversazioni sui Salmi).
Nell’arte la scena della Circoncisione di Gesù apparve tardi ed è abbastanza rara. Lo schema iconografico è ambientato nel tempio di Gerusalemme ed è simile alla Presentazione Gesù al tempio. La miniatura del Menologio di Basilio II è una tra le prime conosciute raffigurazioni.
Nello stesso giorno si commemora uno dei grandi padri della Chiesa Orientale San Basilio Magno.
Frammento dell'icona "Natività del Signore", XVI secolo, chiesa della Protezione della Madre di Dio, villaggio Trushevychi, Museo Nazionale di Leopoli
L'affresco dell'inizio del XVII secolo (1607) nella chiesa greco-cattolica di San Giacomo,
villaggio Powraznik, Nowy Sącz
L'icona ucraina del 1638, parte dell'iconostasi della chiesa di Santi Cosma e Damiano,
villaggio di Velyki Grybovychi vicino a Leopoli
L'icona ucraina del XVII secolo, la scuola di Sudova Vyshnia
L'icona ucraina del XVII secolo, scuola pittorica di Sudova Vyshnia
L'icona del XVII secolo, Museo Nazionale intitolato ad Andrey Sheptytsky a Leopoli
“La circoncisione del Signore” della seconda metà del XVII secolo,
villaggio di Volya Zhovtyanetska. Museo di architettura e vita popolare di Leopoli
L'incisione, Trefologion. Kyiv 1745.
KONTAKION
Il Signore dell’universo si sottomette alla circoncisione e,
qual Buono, circoncide i falli dei mortali.
Oggi concede al mondo la salvezza; gioisce anche nei cieli Basilio,
gerarca del Creatore e datore di luce,
divino iniziatore dei misteri di Cristo.
Ripubblicato ed aggiornato, la data della prima pubblicazione 14/01/2020